Ovvero: come le epoche di grande trasformazione debbano esser accompagnate dal pensiero.
L’ultima opera di cui Kant seguì la pubblicazione ancora in vita, fu “Il conflitto delle facoltà” nel 1798. In essa, il vecchio maestro, sviluppava la tesi tutt’altro che accomodante di un “conflitto della facoltà inferiore con le tre superiori”[1]. Per facoltà, s’intendevano le facoltà universitarie, le tre superiori erano teologia, giurisprudenza e medicina,  quella inferiore era filosofia. Il conflitto era determinato dall’ipotesi kantiana che l’inferiore dovesse ordinare le superiori mentre nei fatti dell’università del tempo, era il contrario. La ragione di ciò, era nella … ragione.
quella inferiore era filosofia. Il conflitto era determinato dall’ipotesi kantiana che l’inferiore dovesse ordinare le superiori mentre nei fatti dell’università del tempo, era il contrario. La ragione di ciò, era nella … ragione.
Nel suo “La filosofia tedesca 1760-1860”[2], Terry Pinkard, cita l’opera e le sue ragioni all’inizio del capitolo IV . Kant è un filosofo da immagine di mondo ovvero uno di quei filosofi che affronta esplicitamente e prioritariamente il problema primo: il rapporto tra Io ed il Mondo ovvero tra il sistema che sono in me ed il sistema che è fuori di me. Secondo Kant, la filosofia, la umana capacità di pensare come si pensa e di pensare tutte le cose nel loro esserci per noi come fenomeni, dovrebbe spingerci a radicarci nella nostra libertà, la libertà di porci come agente giudicante e liberamente trasformante il nostro mondo. La libertà sarebbe l’autodeterminazione ovvero determinare da sé e non essere determinati dal fuori di sé. La visione di Kant, vedeva il pensiero umano, esprimentesi nella sua suprema facoltà filosofica, guidato dalla ragione, intesa come una sorta di organo della libertà.
 Da Kant ad oggi si è poi molto indebolito e problematizzato il concetto di ragione. In effetti avremmo bisogno di fare un riepilogo delle conoscenze critiche che portano ad indebolire la concezione un po’ semplificata nella sua linearità della ragione kantiana, una sorta di Critica della Ragion Complessa. Lo sviluppo delle conoscenze a questo dovrebbe servire, a precisare ampliando, sfumando, sviscerando la complessità poco ordinata che è dentro quei concetti che, in prima istanza, confezioniamo con ben maggior precisione e perfezione formale, al loro inizio. Questo riepilogo e messa in forma sistemica delle ricerche su un concetto allargato di ragione, ricerche che oggi si potrebbero avvalere degli apporti delle scienze cognitive, della neurobiologia, della storia e sociologia delle idee, della psicoanalisi, del superamento del dualismo cartesiano, delle analisi sul ruolo delle ideologie, di quella prima strettoia ordinante che è il linguaggio (logica e semiotica), dell’antropologia, della letteratura ed altre ancora, porterebbe ad annullare il concetto di ragione? Non credo sia possibile farlo e neanche utile. Alfine, noi siamo -anche- in quanto pensiamo, agiamo in quanto pensiamo e quindi non ci è possibile, né conveniente, dimettersi dallo statuto di pensanti. A sua volta, il pensiero, rimane ordinato da ciò che concettualmente chiamiamo ragione sebbene il significato del concetto debba assorbire gran parte della ricerca critica che intorno ad esso si è sviluppata, a partire dalla cosiddetta “scuola del sospetto”[3].
Da Kant ad oggi si è poi molto indebolito e problematizzato il concetto di ragione. In effetti avremmo bisogno di fare un riepilogo delle conoscenze critiche che portano ad indebolire la concezione un po’ semplificata nella sua linearità della ragione kantiana, una sorta di Critica della Ragion Complessa. Lo sviluppo delle conoscenze a questo dovrebbe servire, a precisare ampliando, sfumando, sviscerando la complessità poco ordinata che è dentro quei concetti che, in prima istanza, confezioniamo con ben maggior precisione e perfezione formale, al loro inizio. Questo riepilogo e messa in forma sistemica delle ricerche su un concetto allargato di ragione, ricerche che oggi si potrebbero avvalere degli apporti delle scienze cognitive, della neurobiologia, della storia e sociologia delle idee, della psicoanalisi, del superamento del dualismo cartesiano, delle analisi sul ruolo delle ideologie, di quella prima strettoia ordinante che è il linguaggio (logica e semiotica), dell’antropologia, della letteratura ed altre ancora, porterebbe ad annullare il concetto di ragione? Non credo sia possibile farlo e neanche utile. Alfine, noi siamo -anche- in quanto pensiamo, agiamo in quanto pensiamo e quindi non ci è possibile, né conveniente, dimettersi dallo statuto di pensanti. A sua volta, il pensiero, rimane ordinato da ciò che concettualmente chiamiamo ragione sebbene il significato del concetto debba assorbire gran parte della ricerca critica che intorno ad esso si è sviluppata, a partire dalla cosiddetta “scuola del sospetto”[3].
Se dunque noi siamo -anche- in quanto pensiamo e la facoltà ordinativa del pensare è la ragione e la filosofia è proprio la ragione che giudica se stessa e tutti i contenuti esperienziali, -ergo-, il luogo in cui si ricerca, s’insegna la storia ed il metodo della disciplina, ovvero la sua facoltà (la facoltà di filosofia nell’ambito della pluralità universitaria) non dovrebbe soggiacere alle altre ma semmai porre queste intorno a lei. Se la conoscenza ha organo nella ragione, è la facoltà (nei due sensi) della ragione che dovrebbe coordinare l’indagine sul Tutto.
Il discorso di Kant era eminentemente pratico, riferito cioè alla contingenza dell’ordinamento universitario tedesco della fine del ‘700. Ma se prendiamo il concetto di –università– come un riflesso concreto della nostra concezione del sapere umano, ci si potrebbero fare le stesse domande, a proposito di quella costruzione mentale che chiamiamo –immagine di mondo– poiché l’università altro non è che la messa in pratica della nostra immagine di mondo. Delle immagini di mondo, del nostro sistema di pensiero su noi ed il Mondo, esistono versioni individuali e collettive, originarie di tradizioni di un certo luogo (civilizzazioni) e tempo (storiche), financo di classe e di genere.
dell’ordinamento universitario tedesco della fine del ‘700. Ma se prendiamo il concetto di –università– come un riflesso concreto della nostra concezione del sapere umano, ci si potrebbero fare le stesse domande, a proposito di quella costruzione mentale che chiamiamo –immagine di mondo– poiché l’università altro non è che la messa in pratica della nostra immagine di mondo. Delle immagini di mondo, del nostro sistema di pensiero su noi ed il Mondo, esistono versioni individuali e collettive, originarie di tradizioni di un certo luogo (civilizzazioni) e tempo (storiche), financo di classe e di genere.
Ai tempi di Kant, la filosofia era oggettivamente subordinata alla teologia. Pinkard riferisce che gli insegnanti dell’una lo erano anche dell’altra ma soprattutto quelli di teologia dovevano vagliare, quindi approvare o meno, i testi di filosofia e non il contrario. Questo è ciò che chiamiamo l’ordinatore. L’ordinatore (ciò che dà ordine ed impartisce ordini) principale del sistema di pensiero umano dell’epoca, nell’Europa continentale, era ancora quello teo-religioso.
Quando si fa un breve excursus della storia delle idee e del pensiero, di solito si racconta che la modernità, iniziò con gli scoppiettanti moti rivoluzionari della inversione del punto di vista copernicano, con il dubitabondo (almeno inizialmente) razionalismo cartesiano, con l’osservazione empirica, il riduzionismo, il matematismo scientifico galileiano. La nostra errata idea che le epoche finiscano come finisce il giorno col giorno dopo alla  mezzanotte, così qualche fatto storico è il minuto dopo la mezzanotte che inizia una nuova epoca, non dà conto della realtà. La realtà, essendo complessa, piena di attriti ed inerzie dure da smuovere, di strutture fisiche o fenomeniche che non si lasciano trasformare facilmente, diluisce questo movimento in un processo di lunga e tortuosa durata, ciò che nel montaggio cinematografico si chiama “dissolvenza incrociata”. Un dissolvenza incrociata può durare secoli. Ancora Hegel e Darwin dovettero fare i conti con l’arcigna censura religiosa, che il suo potere censorio fosse nel consiglio dell’ università[4] o nell’opinione pubblica. La scuola del sospetto, Marx, Nietzsche, Freud, è scuola solo per noi, ex-post. Nessuno dei tre era, né poteva essersi trovato a dire quel che ha detto, in una vera e propria “scuola”. Lo stesso Kant, appone una striminzita introduzione al suo volume del 1798, il cui solo scopo è quello di pubblicare la lettera di censura ed ammonimento, ricevuta dal re di Prussia Federico Guglielmo II, a cui segue la sua argomentata risposta difensiva che conclude con un umile “…che in avvenire m’asterrò del tutto, nelle lezioni e negli scritti, da ogni insegnamento pubblico concernente la religione, sia essa naturale o rivelata”[5]. Il vecchio maestro rende pubblico il divieto censorio ma poi si mostra assai meno malleabile del dichiarato ed infatti il tutto fa da premessa ad un libro in tre parti la cui prima termina con una Appendice dal titolo: “Illustrazione del conflitto delle facoltà con l’esempio del dissidio tra la facoltà di teologia e di filosofia”. Obbedisco ma insisto.
mezzanotte, così qualche fatto storico è il minuto dopo la mezzanotte che inizia una nuova epoca, non dà conto della realtà. La realtà, essendo complessa, piena di attriti ed inerzie dure da smuovere, di strutture fisiche o fenomeniche che non si lasciano trasformare facilmente, diluisce questo movimento in un processo di lunga e tortuosa durata, ciò che nel montaggio cinematografico si chiama “dissolvenza incrociata”. Un dissolvenza incrociata può durare secoli. Ancora Hegel e Darwin dovettero fare i conti con l’arcigna censura religiosa, che il suo potere censorio fosse nel consiglio dell’ università[4] o nell’opinione pubblica. La scuola del sospetto, Marx, Nietzsche, Freud, è scuola solo per noi, ex-post. Nessuno dei tre era, né poteva essersi trovato a dire quel che ha detto, in una vera e propria “scuola”. Lo stesso Kant, appone una striminzita introduzione al suo volume del 1798, il cui solo scopo è quello di pubblicare la lettera di censura ed ammonimento, ricevuta dal re di Prussia Federico Guglielmo II, a cui segue la sua argomentata risposta difensiva che conclude con un umile “…che in avvenire m’asterrò del tutto, nelle lezioni e negli scritti, da ogni insegnamento pubblico concernente la religione, sia essa naturale o rivelata”[5]. Il vecchio maestro rende pubblico il divieto censorio ma poi si mostra assai meno malleabile del dichiarato ed infatti il tutto fa da premessa ad un libro in tre parti la cui prima termina con una Appendice dal titolo: “Illustrazione del conflitto delle facoltà con l’esempio del dissidio tra la facoltà di teologia e di filosofia”. Obbedisco ma insisto.
La sostanza è che è l’immagine di mondo di una epoca ad essere ordinata e nell’Europa continentale, sia i cattolici, sia i protestanti che sebbene diversamente strutturati non si sono poi rivelati meno intolleranti[6], esercitarono a lungo la funzione ordinativa. Il sistema di educazione ne è poi un riflesso ed al contempo, una continua riproduzione e propagazione della struttura dell’ordine di una data immagine di mondo.  Certo, la teologia non era più ordinativa in forma solitaria come fu a lungo durante il Medioevo ma in forma condominiale al potere monarchico ed aristocratico. La teologia rimaneva l’ideologia che giustificava il potere aristocratico, come oggi l’economia è l’ideologia che giustifica il potere delle nostre aristocrazie del denaro. Questo ordinatore agisce nelle varie versioni dell’immagine di mondo fino a riflettersi nella stessa costituzione universitaria. Le recenti polemiche sul “sapere utile” ovvero sulla necessità di dare all’università, come fine, la preparazione migliore per entrare efficientemente ed efficacemente negli ingranaggi del sistema economico, riflettono questa realtà dei tempi. Così come la burocrazia prussiana dei tempi andava formata nelle università ordinate da teologia e giurisprudenza, così quella contemporanea va preformata dalla triarchia economico-tecno-scientifica.
Certo, la teologia non era più ordinativa in forma solitaria come fu a lungo durante il Medioevo ma in forma condominiale al potere monarchico ed aristocratico. La teologia rimaneva l’ideologia che giustificava il potere aristocratico, come oggi l’economia è l’ideologia che giustifica il potere delle nostre aristocrazie del denaro. Questo ordinatore agisce nelle varie versioni dell’immagine di mondo fino a riflettersi nella stessa costituzione universitaria. Le recenti polemiche sul “sapere utile” ovvero sulla necessità di dare all’università, come fine, la preparazione migliore per entrare efficientemente ed efficacemente negli ingranaggi del sistema economico, riflettono questa realtà dei tempi. Così come la burocrazia prussiana dei tempi andava formata nelle università ordinate da teologia e giurisprudenza, così quella contemporanea va preformata dalla triarchia economico-tecno-scientifica.
Per tornare ancora alla questione posta da Kant prima di passare a riflettere sul cosa ci può insegnare l’intera faccenda per il nostro oggi, Pinkard ci dice che i suoi seguaci avevano anticipato nei fatti questo insegnamento del vecchio maestro ma non a Konigsberg, bensì a Jena. Qui, sotto la protezione esplicita del molto influente J. W.  Goethe[7], già dal 1784, la facoltà di filosofia non solo era il centro propulsore degli insegnamenti, non solo vi si faceva tanto insegnamento che ricerca ma la posizione che la ragione occupava nell’ordinamento, rispetto a Dio e la Legge, era senz’altro quella ordinativa. A Jena, sarà rettore Reinhold, poi la cattedra specifica vedrà l’impressionante sequenza di Fichte, Shelling ed Hegel.
Goethe[7], già dal 1784, la facoltà di filosofia non solo era il centro propulsore degli insegnamenti, non solo vi si faceva tanto insegnamento che ricerca ma la posizione che la ragione occupava nell’ordinamento, rispetto a Dio e la Legge, era senz’altro quella ordinativa. A Jena, sarà rettore Reinhold, poi la cattedra specifica vedrà l’impressionante sequenza di Fichte, Shelling ed Hegel.
Possiamo concludere questa prima parte del nostro discorso, dicendo che alla fine del XVIII° secolo, in Germania, si rivela un movimento di rivoluzione (di inversione paradigmatica) nel mondo del pensiero mentre in Francia si rivela del mondo sociale. Mentre della vecchia diarchia ordinativa gerarchica, potere aristocratico – potere religioso, in Francia, va in crisi conclamata la prima componente, in Germania, va in crisi la seconda. Ma l’azione sociale senza il pensiero è cieca e la riflessione mentale senza l’azione sociale, è vuota. Così, la Rivoluzione francese romperà la magia del dominio monarchico-aristocratico ma solo dopo decenni perverrà stabilmente alla repubblica  tagliando la testa delle élite ma non a ciò che le produce mentre in Germania, solo dopo decenni comparirà un pensiero (Marx) che tenterà di porsi in oggetto l’azione sociale, con esiti per altro modesti. Nei fatti, l’un movimento e l’altro, toglieranno dal vertice della gerarchia il modo monarchico-religioso, ma solo per preparare l’avvento di quello nuovo saldatosi in Gran Bretagna. Quel paradigma che prevede élite di diversa composizione sociale legate al fare economico di produzione e scambio. Solo così, nel continente, si compirà del tutto la transizione dal Medioevo alla Modernità. La stazione proposta da Kant, quella della libera delibera delle intenzioni ordinate dalla ragione degli uomini associati, verrà saltata dal treno della storia dei fatti e delle idee. All’eteronomia del fare il volere di Dio, subentrerà quella del fare il volere del mercato, alle élite amiche di Dio, subentreranno quella amiche del denaro.
tagliando la testa delle élite ma non a ciò che le produce mentre in Germania, solo dopo decenni comparirà un pensiero (Marx) che tenterà di porsi in oggetto l’azione sociale, con esiti per altro modesti. Nei fatti, l’un movimento e l’altro, toglieranno dal vertice della gerarchia il modo monarchico-religioso, ma solo per preparare l’avvento di quello nuovo saldatosi in Gran Bretagna. Quel paradigma che prevede élite di diversa composizione sociale legate al fare economico di produzione e scambio. Solo così, nel continente, si compirà del tutto la transizione dal Medioevo alla Modernità. La stazione proposta da Kant, quella della libera delibera delle intenzioni ordinate dalla ragione degli uomini associati, verrà saltata dal treno della storia dei fatti e delle idee. All’eteronomia del fare il volere di Dio, subentrerà quella del fare il volere del mercato, alle élite amiche di Dio, subentreranno quella amiche del denaro.
= 0 =
Noi oggi ci troviamo, probabilmente, all’inizio di una nuova transizione occidentale. Quella precedente ebbe motivazioni endogene cioè interne al quadro europeo, quella contemporanea è esogena, dettata cioè da ragioni esterne. Comparativamente a quanto successe nel precedente passaggio, possiamo aspettarci oggi una transizione assai più veloce. L’estrema complessità del sistema occidentale, la sua densità, la pressione che proviene dall’esterno sia essa ambientale, geopolitica, economica, demografica o ideologica, la complessità cioè di ciò che è fuori dell’Occidente ovvero il Mondo, dice che la trasformazione sistemica sarà assai più veloce.
Al momento, ci troviamo in una condizione in cui le trasformazioni concrete e del reale, sono molte di più, molto più veloci e molto più profonde di quanto non si rifletta nel pensiero. Nella precedente trasformazione moderna avevamo: 1) Un polo anglosassone in cui la trasformazione del reale e quella del pensiero procedeva spedita e coordinata con un secolo di vantaggio sul resto del continente; 2) un polo francese in cui si operò solo dopo un secolo l’inizio della trasformazione del reale ma non altrettanto decisivamente quella del pensiero; 3) un polo germanico in cui si operò sincronicamente a quella francese la trasformazione del pensiero ma non quella del reale. Quando 2) e 3) operarono la loro “distruzione”, si ebbe pronta la successiva fase di creazione ma questa fu quella dell’1) che si era già saldato in sistema, tanto reale che ideologico, presso gli anglosassoni. Oggi abbiamo tutt’altra situazione. Essendo la corrente trasformativa esogena e non endogena all’Occidente, è l’intero Occidente a trovarsi in una crisi adattativa tanto delle sue strutture reali, quanto di quelle del suo pensiero. Entrambe resistono ostinatamente anche perché non vedono come potersi trasformare, da ciò il carattere “ontologico” della crisi occidentale.
L’Occidente, oggi, da cosa è ordinato? Sul piano del reale è ordinato dall’economia che esprime élite politiche, finanziarie, economiche e culturali, questa è la nostra monarchia-aristocrazia. Sul piano del pensiero è ordinato dalla tecno-scienza, questa è la nostra religione. Così come la religione esprimeva la sua élite clericale, la scienza esprime la sua élite tecno-scientifica. Così come la teologia faceva da servizio al dominio monarchico-aristocratico, la scienza oggi fa da servizio al potere ordinativo dell’economia e della élite che esprime. Per oggetto e metodo, la scienza è senz’altro altra cosa se non l’opposto della teologia, qui però ci riferiamo alla sua posizione ordinativa[8].
 La volta scorsa, il passaggio dal mondo medioevale a quello moderno, iniziò prima nel reale o nel pensiero? La rivoluzione industriosa che alcuni studiosi mettono oggi a premessa del movimento verso il moderno e che iniziò nel XV° secolo anticipò certo i passaggi successivi ma non si può dargli ruolo maggiore che non di segnale. I movimenti del reale certo si infittirono nella seconda metà del XVI° secolo per poi intensificarsi in quello successivo ma sincronicamente a quelli del pensiero. Il libro di Copernico è del 1543, quello di Bacone del 1620, quello di Galilei è del 1632, quello di Descartes segue nel 1637, completa il percorso Newton alla fine del secolo, nel 1687[9]. La Guerra civile inglese e poi la Gloriosa Rivoluzione, il cambio concreto del paradigma sociale e politico in terra anglo-sassone furono rispettivamente nelle metà e fine del secolo XVII°. In Inghilterra, l’affermazione repentina del nuovo ordinatore scientifico, vide la luce già con la Royal Society che nasce nel 1660. La sua controparte economica, provenne inizialmente, dalla facoltà di filosofia morale[10] ed a livello di pensiero, quasi un secolo dopo, sebbene nei fatti era già in movimento concreto da quasi un secolo. La sentenza è quindi che azione e pensiero coevolvono intrecciati e la disputa tra idealismo e materialismo storico è insensata. Il moderno subentrò al medioevo perché risultò un sistema di azioni pensate che produceva un mondo umano più adatto alle condizioni generali di vita. Fu il suo successo adattativo complessivo a decretarne l’affermazione. Solo la nostra bizzarra configurazione dei saperi separati ci fa leggere la rivoluzione scientifica come un superamento dell’impostazione neo-aristotelica. In effetti, Galilei usò un cannocchiale per cambiare la visione del mondo ma quel cannocchiale era nato nell’artigianato olandese perché la marina commerciale olandese andava lungo le lunghe coste africane a cercar rifornimenti e non volendo accostare ogni volta per scendere a dare uno sguardo si ebbe vantaggio dal dare lo sguardo dal mare.
La volta scorsa, il passaggio dal mondo medioevale a quello moderno, iniziò prima nel reale o nel pensiero? La rivoluzione industriosa che alcuni studiosi mettono oggi a premessa del movimento verso il moderno e che iniziò nel XV° secolo anticipò certo i passaggi successivi ma non si può dargli ruolo maggiore che non di segnale. I movimenti del reale certo si infittirono nella seconda metà del XVI° secolo per poi intensificarsi in quello successivo ma sincronicamente a quelli del pensiero. Il libro di Copernico è del 1543, quello di Bacone del 1620, quello di Galilei è del 1632, quello di Descartes segue nel 1637, completa il percorso Newton alla fine del secolo, nel 1687[9]. La Guerra civile inglese e poi la Gloriosa Rivoluzione, il cambio concreto del paradigma sociale e politico in terra anglo-sassone furono rispettivamente nelle metà e fine del secolo XVII°. In Inghilterra, l’affermazione repentina del nuovo ordinatore scientifico, vide la luce già con la Royal Society che nasce nel 1660. La sua controparte economica, provenne inizialmente, dalla facoltà di filosofia morale[10] ed a livello di pensiero, quasi un secolo dopo, sebbene nei fatti era già in movimento concreto da quasi un secolo. La sentenza è quindi che azione e pensiero coevolvono intrecciati e la disputa tra idealismo e materialismo storico è insensata. Il moderno subentrò al medioevo perché risultò un sistema di azioni pensate che produceva un mondo umano più adatto alle condizioni generali di vita. Fu il suo successo adattativo complessivo a decretarne l’affermazione. Solo la nostra bizzarra configurazione dei saperi separati ci fa leggere la rivoluzione scientifica come un superamento dell’impostazione neo-aristotelica. In effetti, Galilei usò un cannocchiale per cambiare la visione del mondo ma quel cannocchiale era nato nell’artigianato olandese perché la marina commerciale olandese andava lungo le lunghe coste africane a cercar rifornimenti e non volendo accostare ogni volta per scendere a dare uno sguardo si ebbe vantaggio dal dare lo sguardo dal mare.
= 0 =
Quello che preoccupa particolarmente della nostra condizione occidentale contemporanea è l’inerzia con cui nel pensiero, si riflettono i potenti movimenti della nuova realtà. Le nostre facoltà tanto mentali che universitarie, continuano ad avere ad ordinatore la scienza[11]. La nostra mono-aristocrazia elitaria espressa dal modo economico è sempre più ferocemente in sella, quasi nella pari deriva assolutista che visse quella medioevale prima del grande scontro (perso) con l’inizio del moderno. Pensiero (immagine di mondo) e luogo di diffusione (università) sono ancora determinati da teorie di due, tre secoli fa.
La scienza, si sa, non ha fini che non siano gnoseologici e comunque non li stabilisce internamente[12] e non è possibile una scienza dei fini poiché i fini sono il regno della possibilità quindi della libertà, quindi del mondo umano, non di quello naturale che come è noto, è necessitato. Gran parte del tempo impiegato nel dibattito comparativo tra scienza e non scienza è buttato sulla questione del metodo ma la sostanza che divide le due famiglie di conoscenza è nell’oggetto e la pretesa di trasferire un metodo (scientifico) che funziona su oggetti non intenzionali, per conoscere oggetti intenzionali e le loro opere (gli uomini) non ha senso. Altresì, il fine dato dall’economia sembra oggi impossibile alla sua stessa produzione. Il “maggior bene per il maggior numero” è oggi ampiamente tradito e strutturalmente in crisi tanto nella prima parte della proposizione, che nella seconda. Un 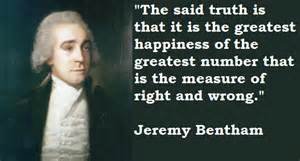 certo benessere materiale l’abbiamo raggiunto ma per poi scoprire che è solo una parte del bene umano e tra l’altro, faremo sempre più fatica, qui in Occidente, a garantirlo con continuità. Quanto al maggior numero, questo si è reso solo “tendenzialmente possibile” e solo in minima parte, in una finestra storica assai contenuta (un paio di decenni dopo la Seconda Guerra mondiale), con persistenti asimmetrie poiché non è ovviamente fine dell’economia occuparsi della giustizia distributiva. Oggi poi questo maggior numero, al contrarsi delle condizioni di possibilità per la produzione del profitto che è la forza movente del sistema economico che dovrebbe produrre il benessere, è diventato il minor numero. Infine, non è certo un fine universale perché l’entrata in crisi del relativo maggior benessere e del relativo maggior numero è, qui in Occidente, coinciso con il movimento di ricerca di nuovo benessere dei non occidentali che sono in molto maggior numero. L’economia moderna, lascia il sospetto profondo, si tratti di un gioco a somma zero e che la crescita di chi subiva, porti alla decrescita di chi dominava[13], mentre è certo che ha un serio problema con l’operatore aritmetico della divisione poiché per funzionare a modo suo, deve presupporre più ricchezza nel minor numero per un modesto benessere per il maggior numero.
certo benessere materiale l’abbiamo raggiunto ma per poi scoprire che è solo una parte del bene umano e tra l’altro, faremo sempre più fatica, qui in Occidente, a garantirlo con continuità. Quanto al maggior numero, questo si è reso solo “tendenzialmente possibile” e solo in minima parte, in una finestra storica assai contenuta (un paio di decenni dopo la Seconda Guerra mondiale), con persistenti asimmetrie poiché non è ovviamente fine dell’economia occuparsi della giustizia distributiva. Oggi poi questo maggior numero, al contrarsi delle condizioni di possibilità per la produzione del profitto che è la forza movente del sistema economico che dovrebbe produrre il benessere, è diventato il minor numero. Infine, non è certo un fine universale perché l’entrata in crisi del relativo maggior benessere e del relativo maggior numero è, qui in Occidente, coinciso con il movimento di ricerca di nuovo benessere dei non occidentali che sono in molto maggior numero. L’economia moderna, lascia il sospetto profondo, si tratti di un gioco a somma zero e che la crescita di chi subiva, porti alla decrescita di chi dominava[13], mentre è certo che ha un serio problema con l’operatore aritmetico della divisione poiché per funzionare a modo suo, deve presupporre più ricchezza nel minor numero per un modesto benessere per il maggior numero.
Eppure, il dominio ordinativo della scienza e dell’economia non sembra scalfirsi di un elettrone. L’unico dominio libero da questa doppia gerenza è la critica ma la critica ha più la funzione di migliorare le performance di ciò che critica che non di creare una alternativa[14]. Questa si è rivelata infine la funzione della ragione dialettica. Non è che Copernico o  Descartes o Galilei o Bacone o Newton siano stati dei Feuerbach e non è che Feuerbach diede poi vita a chissà quali cambiamenti concreti[15], così in fondo Marx. Così, l’ateismo più o meno dissimulato degli illuministi francesi e di alcuni inglesi non produssero mondo solo perché attaccavano frontalmente l’ordinatore principale del pensiero. I primi moderni hanno promosso una nuova strada, che poi questa fosse in alternativa a quella della provvidenza divina era un fatto, non un intendimento programmatico. Così a noi è chiesto un pensiero che prometta un modo nuovo di stare al mondo, modo che non sorgerà dalla critica dell’economia politica e della sua tarda e stanca ideologia neoliberista[16].
Descartes o Galilei o Bacone o Newton siano stati dei Feuerbach e non è che Feuerbach diede poi vita a chissà quali cambiamenti concreti[15], così in fondo Marx. Così, l’ateismo più o meno dissimulato degli illuministi francesi e di alcuni inglesi non produssero mondo solo perché attaccavano frontalmente l’ordinatore principale del pensiero. I primi moderni hanno promosso una nuova strada, che poi questa fosse in alternativa a quella della provvidenza divina era un fatto, non un intendimento programmatico. Così a noi è chiesto un pensiero che prometta un modo nuovo di stare al mondo, modo che non sorgerà dalla critica dell’economia politica e della sua tarda e stanca ideologia neoliberista[16].
Molto di questo impasse lo dobbiamo alla storia precedente. I francesi fecero una rivoluzione ma non costruirono molto pensiero attorno ed infatti lasciarono intatta la struttura del dominio delle élite salvo cambiarne poi la composizione sociale (da  aristocrazia e clero a borghesia). I tedeschi produssero invece molto pensiero ma solo dopo un secolo da Kant, riuscirono a costituirsi come stato nazione moderno e solo per fare due sanguinose guerre mondiali prima di rassegnarsi a diventare un sistema anglosassone (democrazia liberale intorno all’ordinatore economico a sua volta orientato dal paradigma mercantilista). L’Idealismo tedesco, la matrice di ogni pensiero critico resistente al dominio del doppio paradigma economia-scienza, ha fallito. Nessuna alternativa abbiamo dopo centocinquanta anni, se non continuare a criticare e magari farci dare una cattedra per insegnare a criticare meglio e di più. Vien quasi il dubbio che questa funzione critica sia organica al corso dominante, vista la sua oggettiva impotenza concreta a produrre un diverso mondo reale.
aristocrazia e clero a borghesia). I tedeschi produssero invece molto pensiero ma solo dopo un secolo da Kant, riuscirono a costituirsi come stato nazione moderno e solo per fare due sanguinose guerre mondiali prima di rassegnarsi a diventare un sistema anglosassone (democrazia liberale intorno all’ordinatore economico a sua volta orientato dal paradigma mercantilista). L’Idealismo tedesco, la matrice di ogni pensiero critico resistente al dominio del doppio paradigma economia-scienza, ha fallito. Nessuna alternativa abbiamo dopo centocinquanta anni, se non continuare a criticare e magari farci dare una cattedra per insegnare a criticare meglio e di più. Vien quasi il dubbio che questa funzione critica sia organica al corso dominante, vista la sua oggettiva impotenza concreta a produrre un diverso mondo reale.
= 0 =
Possiamo però imparare dagli errori e tornare di nuovo al conflitto delle facoltà cioè a domandarci quale pensiero possa sovvertire l’edificio cognitivo responsabile dello stato di cose che vogliamo e dobbiamo cambiare. Karl Jaspers nei suoi scritti sull’Università (Idee der Universitat, 1923, 1946) lamentava la deriva in un aggregato incoerente di discipline che hanno scopi eterogenei, senza connessione, senza fini consapevoli e  deliberati da oscure funzioni ordinative quali la politica delle élite, la tecno-struttura amministrativa, l’interesse utilitario economico. Di nuovo, sembra necessario porre il problema delle relazioni tra facoltà superiori (economia, scienza) ed inferiori (filosofia) e nello specifico, quella facoltà inferiore, la filosofia appunto, che è l’unico sapere umano che ha in oggetto tanto il sapere in sé, quanto l’umano in sé e soprattutto, i fini di entrambi, la loro ragion pratica. Certo non ci stiamo appellando alla filosofia della logica, del linguaggio, dell’ermeneutica, della decostruzione, dei mille rivoli specializzati che corrono appresso alle varie espressioni fenomeniche del mondo (oggi abbiamo addirittura le ontologie regionali e la dissipazione fenomenologica post-moderna). Ci stiamo appellando ad una filosofia che non c’è e quindi la prima strada da aprire è quella per una nuova ricerca nella filosofia stessa.
deliberati da oscure funzioni ordinative quali la politica delle élite, la tecno-struttura amministrativa, l’interesse utilitario economico. Di nuovo, sembra necessario porre il problema delle relazioni tra facoltà superiori (economia, scienza) ed inferiori (filosofia) e nello specifico, quella facoltà inferiore, la filosofia appunto, che è l’unico sapere umano che ha in oggetto tanto il sapere in sé, quanto l’umano in sé e soprattutto, i fini di entrambi, la loro ragion pratica. Certo non ci stiamo appellando alla filosofia della logica, del linguaggio, dell’ermeneutica, della decostruzione, dei mille rivoli specializzati che corrono appresso alle varie espressioni fenomeniche del mondo (oggi abbiamo addirittura le ontologie regionali e la dissipazione fenomenologica post-moderna). Ci stiamo appellando ad una filosofia che non c’è e quindi la prima strada da aprire è quella per una nuova ricerca nella filosofia stessa.
 Ma dobbiamo anche denunciare lo scandalo della nostra rinuncia a pensare attivamente l’intero. Da Agostino a von Hayek è un continuo di pensatori, sacerdoti del sistema ordinativo vigente, che intimano all’uomo di rendersi passivo, di non azzardarsi a porsi il problema di come fare il Mondo. Se non lo pensiamo non potremo agirlo, se non lo agiremo intenzionalmente in autonomia ne subiremo l’eteronomia, se continueremo a subirne l’eteronomia non saremo mai pienamente umani ma sempre e solo pre-umani. Quella “pigrizia e viltà” responsabile della nostra “minorità” ovvero “l’incapacità di servirsi della propria intelligenza” (Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo, I. Kant, 1783) che ci lascia “minorenni a vita”.
Ma dobbiamo anche denunciare lo scandalo della nostra rinuncia a pensare attivamente l’intero. Da Agostino a von Hayek è un continuo di pensatori, sacerdoti del sistema ordinativo vigente, che intimano all’uomo di rendersi passivo, di non azzardarsi a porsi il problema di come fare il Mondo. Se non lo pensiamo non potremo agirlo, se non lo agiremo intenzionalmente in autonomia ne subiremo l’eteronomia, se continueremo a subirne l’eteronomia non saremo mai pienamente umani ma sempre e solo pre-umani. Quella “pigrizia e viltà” responsabile della nostra “minorità” ovvero “l’incapacità di servirsi della propria intelligenza” (Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo, I. Kant, 1783) che ci lascia “minorenni a vita”.
Noi auspichiamo da tempo che il più generale dei saperi, s’incarichi del necessario generalismo di cui oggi, in tempi dominati dallo specialismo, c’è prioritariamente bisogno. Un generalismo che: a) non sia in alternativa ma in complementarietà allo specialismo; b) un generalismo che sia anche sintesi degli specialismi, che apprenda da 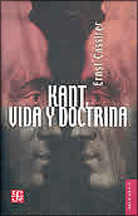 questi e non si sogni di dettarne unilateralmente metodi e principi, bensì ricerchi sui fini per conto dell’umano[17]. La filosofia potrebbe porsi l’ambizione non del vertice di un pensiero gerarchico ma di circolo centrale che riceve e dà a tutta la circonferenza orizzontale dei saperi. Quello che intendiamo è che se oggi la relazione tra noi ed il mondo si è fatta molto complessa, se più complesso deve essere il concetto che abbiamo di Io e Noi, se più complesso è il mondo in sé per sé, se molto complessa e sempre più problematica è la relazione tra queste due sfere, questo sapere con ambizioni centrali di coordinamento e sintesi, dovrebbe riflettere questa matrice complessa che è il discontinuo più evidente della nostra epoca.
questi e non si sogni di dettarne unilateralmente metodi e principi, bensì ricerchi sui fini per conto dell’umano[17]. La filosofia potrebbe porsi l’ambizione non del vertice di un pensiero gerarchico ma di circolo centrale che riceve e dà a tutta la circonferenza orizzontale dei saperi. Quello che intendiamo è che se oggi la relazione tra noi ed il mondo si è fatta molto complessa, se più complesso deve essere il concetto che abbiamo di Io e Noi, se più complesso è il mondo in sé per sé, se molto complessa e sempre più problematica è la relazione tra queste due sfere, questo sapere con ambizioni centrali di coordinamento e sintesi, dovrebbe riflettere questa matrice complessa che è il discontinuo più evidente della nostra epoca.
Una filosofia che ci aiuti a comprendere il nostro tempo col pensiero ma che ci aiuti anche a recuperare autonomia nella relazione, a porci in condizione di fare progetti sul mondo, condividerli per poi metterli in pratica. Progetti umani, individuali e sociali, intenzionali, che rovescino la tradizione eteronoma dell’ordinatore esterno quale si è avuto lungo i diecimila anni della storia delle società complesse ovvero farsi guerra incessantemente, obbedire ad una narrazione religiosa, agitarsi e farsi agitare da mani invisibili. Ordinatori variabili della costante dell’assetto del potere sociale che da sempre vede Pochi (generali, sacerdoti, aristocratici, capitalisti) governare Molti. Una filosofia della complessità, tanto interpretativa che pratica (cioè con fini etici e politici) che ci metta in condizione di riprendere l’umano cammino per l’emancipazione dalla nostra infanzia e la maggior libertà. A questa ricerca dedicheremo altri, prossimi, interventi.
0 = 0
[1] Immanuel Kant, Il conflitto delle facoltà, Morcelliana, Brescia, 1994
[2] Terry Pinkard, La filosofia tedesca 1760-1860. L’eredità dell’idealismo, Einaudi, Torino, 2014
[3] Definizione di Paul Ricoeur
[4] Chissà se una certa nebulosità terminologica che affligge gli scritti di Hegel, non derivi consciamente o inconsciamente da un freno a trasferire idee chiare e distinte che pure dobbiamo presupporre avesse, in pari linguaggio per, diciamo così, “seppellire” i concetti dentro una coltre che scoraggiasse i meno motivati ad avventurarvisi. I filosofi moderni, tra l’altro, non avevano solo problemi con l’istituzione costituita ma molto spesso, anche con le opinioni pubbliche, non memo ottuse. Alcune sue biografie, basandosi sulle testimonianze di alcuni ex-allievi, supportano questa ipotesi.
[5] I. Kant, Il conflitto delle facoltà, op. cit., Prefazione, pg. 63
[6] Gli Stati Uniti d’America contemporanei, ne sono la dimostrazione con il creazionismo e la variante deista del disegno intelligente che sono creduti da ben più della metà della popolazione di quella che altresì, risulta la nazione più capitalistico-scientifica del mondo. Passi per il capitalismo come ha ben illustrato Max Weber (intendo il legame sinergico tra protestantesimo e capitalismo) ma con certa scienza, quella ad esempio evoluzionistica, il conflitto permane intatto. Quello che agisce, infatti, è il decisivo scontro tra ordinatori.
[7] Goethe era stato precettore del Duca di Weimar, Carlo Augusto, dei cui possedimenti Jena era parte. In quegli anni, Goethe scalerà diversi gradi dell’ordine massonico e nel 1783, aderirà a gli Illuminati.
[8] Altresì, lungi da noi l’intenzione di criticare la tecno-scienza in assoluto. Solo nella relativa configurazione e finalità che mostra oggi e più specificatamente ancora, nella sua presunzione di poter fare da “ordinatore”, quando -tra l’altro- è ordinata-. Non v’è dubbio che la tecnica e la scienza facciano parte delle conquiste umane e debbano partecipare da par loro al concerto delle conoscenze complesse. Non è sostituendo l’ordinatore che sbloccheremo la nostra atavica paura della piena responsabilità del nostro essere ma proprio sostituendo la geometria dei saperi. Questa potrebbe avere la nuova filosofia come ordinatore nel senso di dare ordine (mettere in forma) ma non dare ordini (prescrivere). La prescrizione dovrebbe essere propria della decisione umana associata. Ne conseguirebbe, il ruolo ordinativo (nel senso di dare ordini) del politico, cioè che pertiene alla polis, al vivere umano associato appunto. Si tratta, evidentemente, di un modello ideale di democrazia (informata) radicale.
[9] Rispettivamente: De revolutionibus orbium coelestium, Novum Organum, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (il Saggiatore è del 1623), Discorso sul metodo, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.
[10] Questa era la cattedra di Adam Smith, ai tempi in cui insegnò all’Università di Glasgow (1753-1766).
[11] Non è il caso dell’Italia ma non ne gioirei. L’università italiana è una fucina di “disadattati intellettuali” ovvero persone la cui formazione risulta spesso inutile sia ad integrarsi nel mondo come è, sia a promuovere un altro mondo, un mondo come dovrebbe essere. Sulla funzione formatrice critica diremo dopo.
[12] La scienza, a maggior ragione oggi in cui il genio individuale poco può fare in tempi di lavoro di team, acceleratori miliardari, computer con sovrumana potenza di calcolo e costo altissimo di molte sperimentazioni, prende i suoi fini da chi ne indirizza l’attenzione, che è poi chi finanzia il suo ricercare.
[13] L’economia moderna sembrerebbe così un sistema termodinamico chiuso, il cui destino è lo stato di finale entropia. E’ per questo che ultimamente si paventa addirittura un prossimo secolo di stagnazione? (Ammirevole il coraggio chi si arrischia a fare previsioni da qui ad un secolo…)
[14] La fede nella potenza creatrice della dialettica di tipo hegeliano, ripresa nella struttura dell’impianto marxiano, si sta rivelando, appunto, una fede ed ogni fede, prima o poi, risulta mal riposta.
[15] Non è cioè dalla critica diretta e dirimpetta delle tesi teologiche che nasce la modernità ma dalla speciazione di un nuovo paradigma (la scienza) che poi mostra capacità ordinative, tanto del pensiero, quanto del reale. Addirittura, retrocedendo nella genealogia dei saperi, fu la tecnica a dare inizio a tutto, la tecnica della rivoluzione industriosa del XV° e XVI° secolo. Tale tecnica, a sua volta, non è figlia di alcun intento organizzato intenzionalmente ma di una sorta di inversione dei rapporti tra Io e Mondo. Da passivi, ad attivi.
[16] Si potrebbe supporre che il “neo-liberismo” appartenga alla categoria dei pensieri disperati, di quei pensieri cioè che, come l’Inquisizione, corrispondono alla fasi pre-morienti dei cicli, le fasi in cui il pensiero annusa il disadattamento del suo modello e s’irrigidisce. Ve ne sono tutti i sintomi. La sua sostanza è riprendere a modo suo (estraendolo da un libro di più di mille pagine scritto duecentoquaranta anni fa) un concetto idealizzato -il mercato-, e riproporlo in salsa contemporanea, da cui l’uso del “neo” che è sempre indicatore di mancanza sostanziale di novità come ben possono insegnare i pubblicitari. Che noi si sia in una fase di pensiero stanco è rivelato anche dall’inflazione nell’uso di “post”-qualsiasicosa. Neo e post prorogano il pensiero vecchio.
[17] Un riferimento per questo modello potrebbe trovarsi in Kant stesso. Kant era un onnivoro studioso degli oggetti del pensiero umano lungo la prima fase del suo pensiero, la fase precedente le tre critiche, la cui prima completò quando aveva già 57 anni. Kant studiava ed insegnava geografia fisica ed antropologia che riteneva le due materie propedeutiche necessarie ad ogni formazione del pensiero umano. Nota è la sua conoscenza approfondita al più alto livello delle conoscenze della sua epoca di fisica,  matematica ed astronomia. Studiò e fece riflessione sulla storia, sulla politica, sul diritto, così come su i costumi mondani, addirittura sulla moda nonché le nuove scienze della vita che poi diverranno la biologia. Noti, i suoi interventi sulla credenza religiosa e la teologia razionale. Il motto che ispirava il suo atteggiamento conoscitivo si potrebbe trovare in una commedia del 165 a.c. di Publio Terenzio Afro: “Sono un essere umano, è ritengo che tutte le cose umane siano fatti miei”, conosciuto anche come “Nulla che sia umano mi è estraneo”. Poiché si convinse che anche tutto ciò che è fuori dell’umano, ciò che chiamiamo il Mondo, lo diventa perché effetta (produce effetti) i nostri sensi, tutti gli oggetti del nostro sentire e pensare hanno rilievo umano. Altresì, convincendosi successivamente che tutto ciò afferisce ad una funzione centrale ed unificante del nostro pensiero che chiamava “Io penso” se ne può dedurre un assetto per il quale ogni Io penso dovrebbe volgersi anche verso l’atteggiamento di comprensione generale di sé, del Mondo e soprattutto della loro relazione. A questo assetto che Ernst Cassirer nel suo “Vita e dottrina in Kant” (La nuova Italia, 1997, pg.53) chiama “tendenza al tutto”, andrebbe dedicata una ricerca sulla possibilità di una filosofia della complessità poiché entrambi, i soggetti-oggetti ed ancorpiù la loro messa in relazione, sono connotati da ciò che fa il concetto di “complessità”.
matematica ed astronomia. Studiò e fece riflessione sulla storia, sulla politica, sul diritto, così come su i costumi mondani, addirittura sulla moda nonché le nuove scienze della vita che poi diverranno la biologia. Noti, i suoi interventi sulla credenza religiosa e la teologia razionale. Il motto che ispirava il suo atteggiamento conoscitivo si potrebbe trovare in una commedia del 165 a.c. di Publio Terenzio Afro: “Sono un essere umano, è ritengo che tutte le cose umane siano fatti miei”, conosciuto anche come “Nulla che sia umano mi è estraneo”. Poiché si convinse che anche tutto ciò che è fuori dell’umano, ciò che chiamiamo il Mondo, lo diventa perché effetta (produce effetti) i nostri sensi, tutti gli oggetti del nostro sentire e pensare hanno rilievo umano. Altresì, convincendosi successivamente che tutto ciò afferisce ad una funzione centrale ed unificante del nostro pensiero che chiamava “Io penso” se ne può dedurre un assetto per il quale ogni Io penso dovrebbe volgersi anche verso l’atteggiamento di comprensione generale di sé, del Mondo e soprattutto della loro relazione. A questo assetto che Ernst Cassirer nel suo “Vita e dottrina in Kant” (La nuova Italia, 1997, pg.53) chiama “tendenza al tutto”, andrebbe dedicata una ricerca sulla possibilità di una filosofia della complessità poiché entrambi, i soggetti-oggetti ed ancorpiù la loro messa in relazione, sono connotati da ciò che fa il concetto di “complessità”.







Caro Pierluigi, il tuo saggio è davvero molto interessante e lavora attorno a quel pensiero “costruttivo” che già introducevi altrove, sostenuto qui da un suggestivo quadro dell’occidente, che condivido. Sono della tua battaglia, cercherò di tornar sui tuoi argomenti con ragione -purtroppo il lavoro salariato è ancora la mia condizione “materiale”- intanto sottolineo un ricordo storico importante del tuo scritto: la successione degli idealisti di Jena. Sto andando all’aeroporto a prendere mio figlio Francesco, che sta studiando filosofia a Jena (in particolare Hegel e lo scetticismo antico); in primavera sono stato da lui e mi ha molto commosso quel clima che li si può percepire ancora, nella romantikerhaus, in quel convivio dove nel volgere di poco più di un decennio si svolse una enorme produzione ideale. Tempo fa ti interrogavi sulle modalità con cui Fichte fece “sparire la cosa in sé” di Kant, proverò a sentire l’opinione di mio figlio. Un caro saluto
Mi fa molto piacere sapere della scelta di tuo figlio. Hegel stesso ebbe, all’inizio un invaghimento per lo scetticismo e del resto fu Schulze con l’Enesidemo ad iniziare la contestazione del kantismo. Stavo leggendo il bel saggio di Pinkard che è citato nell’articolo ma mi son dovuto fermare proprio a dopo del passaggio Reinhold-Schulze-Fichte per ritornare ancora a Kant, al saggio oggetto dell’articolo ed alla Vita e Dottrina di Cassirer. Spero di aver l’opportunità di incontrarti un giorno di persona e chiacchierarcela un po’. A presto.